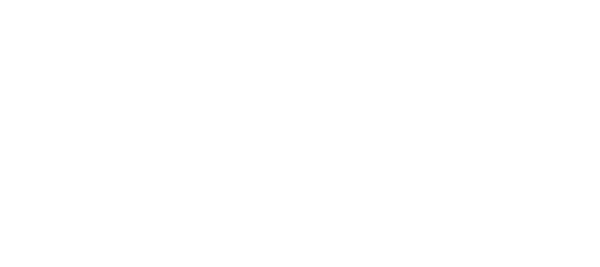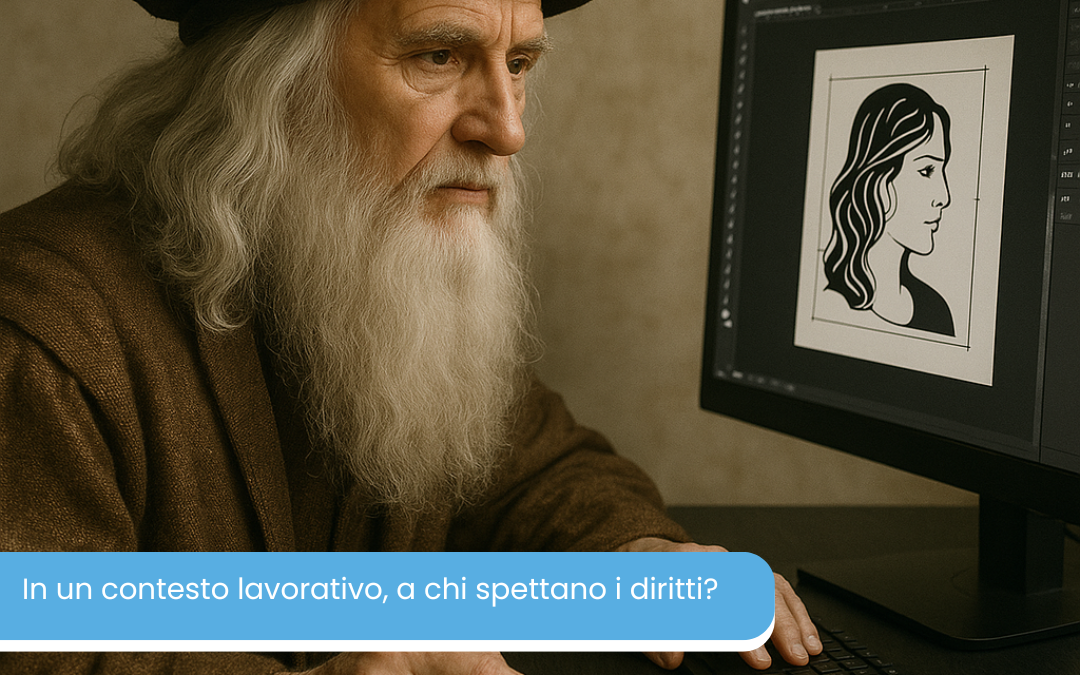Nel mondo della creatività e delle arti, spesso si dà per scontato che l’autore sia anche l’unico titolare dei diritti sull’opera. Ma cosa accade quando l’opera viene realizzata nel contesto di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo? A chi spettano i diritti di sfruttamento economico? La risposta, come spesso accade in ambito giuridico, è: dipende. E non poco.
Cosa dice la legge: tra norma e prassi
La Legge sul diritto d’autore (n. 633/1941) prevede – agli articoli 12-bis e 12-ter – che, in assenza di patti contrari, i diritti economici su software, banche dati e disegni industriali realizzati da un dipendente spettino al datore di lavoro. Fin qui tutto chiaro. Ma la giurisprudenza ha esteso questa impostazione anche ad altre opere dell’ingegno, incluse scenografie, grafiche, opere teatrali, ecc., in presenza di un rapporto di lavoro subordinato o persino autonomo, a condizione che vi sia un’attività creativa specificamente commissionata.
In sostanza, se l’opera nasce nell’esecuzione delle mansioni o su commissione, i diritti patrimoniali (cioè lo sfruttamento economico) spettano al datore o committente. I diritti morali (come il diritto al nome e all’integrità dell’opera), invece, restano sempre in capo all’autore.
Il caso Musenich: quando i bozzetti vanno in scena… senza l’autore
La recente sentenza del Tribunale di Genova (n. 157/2024) fornisce un caso emblematico. Enrico Musenich, scenografo e dipendente del Teatro Carlo Felice, ha rivendicato la violazione dei propri diritti d’autore per numerosi spettacoli da lui curati: da “Il turco in Italia” a “Rigoletto”, passando per “Lucia di Lammermoor” e “La vedova allegra”.
In particolare, ha contestato:
- Il mancato pagamento per l’ideazione e l’utilizzo delle sue scenografie
Musenich ha richiesto il pagamento dei compensi relativi non solo alla realizzazione materiale dei bozzetti e degli allestimenti, ma anche al loro riutilizzo in repliche, tournée e rappresentazioni successive in Italia e all’estero. In molti casi, il suo nome compariva nei materiali promozionali, ma i pagamenti previsti da contratto (o attesi per prassi) non sono mai arrivati. La questione centrale è: il riconoscimento creativo può bastare in assenza di una precisa pattuizione economica? Per i giudici, la risposta è stata no. - La mancata indicazione del suo nome come autore
Il diritto morale alla paternità dell’opera prevede che l’autore venga sempre riconosciuto come tale, anche quando i diritti patrimoniali siano trasferiti. Tuttavia, in alcuni riallestimenti – in particolare della scenografia del Rigoletto – il nome di Musenich non è stato riportato. Secondo il Tribunale, ciò è lecito solo se l’opera è stata modificata in misura tale da perdere l’identità originaria. In caso contrario, l’omissione può costituire una violazione. - L’uso delle sue opere in produzioni successive senza autorizzazione o compenso
Uno dei punti più controversi riguarda il riutilizzo e la trasposizione all’estero di opere scenografiche ideate da Musenich. Secondo l’artista, la Fondazione avrebbe ceduto i suoi lavori a teatri stranieri (in Cina, Slovenia, Oman) senza il suo consenso né il pagamento di alcun diritto. La corte ha distinto tra opere realizzate durante il rapporto di lavoro – per cui i diritti spettano al datore – e quelle prodotte in regime di contratto d’opera, dove è necessario rispettare le clausole pattuite. Tuttavia, in assenza di prove di inadempimento specifico, alcune delle sue richieste sono state respinte.
Creatività su commissione: attenzione ai contratti
Il punto centrale che emerge dalla sentenza è la rilevanza del contratto. Quando le opere vengono realizzate fuori dall’orario di lavoro o durante periodi di aspettativa, e vi è un contratto d’opera con riconoscimento esplicito dei diritti d’autore o di compensi specifici, questi vanno onorati. Viceversa, se non si pattuisce nulla, i diritti patrimoniali restano in capo al datore o committente, anche in caso di mancato pagamento.
Non basta quindi “aver creato qualcosa” per poterne rivendicare lo sfruttamento economico: serve chiarezza contrattuale e – in caso di contestazioni – capacità di dimostrare l’inadempimento.
Conclusione
L’arte e il diritto non sempre parlano la stessa lingua, ma quando si incontrano sul palcoscenico delle norme, la chiarezza è tutto. Se sei un professionista creativo, un datore di lavoro o una fondazione culturale, non lasciare al caso la gestione dei diritti sulle opere commissionate.
Hai dubbi su contratti di lavoro creativo o vuoi tutelare meglio i tuoi diritti d’autore?
Contattaci oggi: il nostro team legale è al tuo fianco per aiutarti a evitare contenziosi e valorizzare le tue opere in modo trasparente.